Come vado da tempo spiegando, l’organizzazione della mobilità urbana nelle città italiane risponde a logiche diverse da quelle che regolano le altre grandi capitali del mondo industrializzato. Partendo dall’esempio di recenti fatti romani illustrerò come lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile venga non solo ignorato, bensì scientemente ostacolato dalle nostre istituzioni .
I mass media ci raccontano ormai da decenni di città soffocate dal traffico e dall’inquinamento, con progressivo aumento di patologie: allergie, malattie delle vie respiratorie, tumori, complicazioni cardiovascolari legate alla vita sedentaria, malattie da stress e via elencando. A completare questo quadro drammatico c’è poi l’incidentalità, che sforna un computo di morti, feriti ed invalidi tipico di una guerra a bassa intensità. Ci si potrebbe aspettare che una situazione tanto grave attivi reazioni urgenti da parte delle varie entità di governo del paese, tuttavia questo non avviene. Per l’esattezza non è mai avvenuto.
Continuiamo a vivere in città regolate da un Codice della Strada emanato negli anni ’50 e, a giudicare dagli effetti, direttamente redatto dagli allora dirigenti della FIAT. Un’organizzazione delle strade già in partenza molto discutibile che, proiettata ad oltre mezzo secolo di distanza, ha letteralmente intasato gli spazi urbani di veicoli privati in transito a velocità eccessive.
Ridurre il carico di veicoli che circolano nelle città è ovviamente possibile. Gli interventi da porre in atto ricadono in due grandi tipologie: limitazioni degli accessi veicolari da un lato, facilitazione dell’utilizzo di modalità di trasporto alternative all’automobile dall’altro. L’imposizione di limitazioni agli automobilisti ottiene per solito una levata di scudi da parte della cittadinanza, ed è facilmente strumentalizzabile come ‘liberticida’ dai conservatori dello status quo (anche se quella che si intende limitare è la libertà di far male agli altri). Una strategia meno apertamente conflittuale comporta la messa in sicurezza degli utenti leggeri (ciclisti, pedoni ed utenti del trasporto pubblico) nell’idea di ridurre il carico veicolare sulle strade semplicemente favorendo modalità diverse di spostamento. Nelle principali capitali dei paesi occidentali si va operando ormai da anni un mix delle due opzioni.
L’intervento più semplice di sistemazione ciclabile prende il nome di ‘bike lane’ e consiste nella separazione dei flussi a mezzo di semplice segnaletica orizzontale: una riga bianca disegnata a terra con pittogrammi di bici intervallati fra loro. Questa sistemazione non modifica l’ampiezza della sede stradale, ma consente di indicare la porzione di suolo utilizzata dai ciclisti ed ottenere che gli automobilisti se ne tengano a debita distanza. Ovviamente la convivenza di veicoli tanto diversi in assenza di una separazione fisica richiede che le velocità relative siano relativamente basse, e non è pertanto applicabile sulle tratte stradali ‘ad alto scorrimento’.
Gli antesignani di questa soluzione sono stati olandesi e danesi, questo è un esempio di ‘bike lane’ a Copenhagen.

Qui invece siamo a Parigi, dove nel corso degli ultimi dieci anni le corsie ciclabili si sono moltiplicate rapidamente.

Ed ecco Londra, dove pure, a partire dall’ingresso nel 21° secolo, le politiche di incentivazione della mobilità ciclistica e pedonale sono state diffuse e radicali.

Perfino a New York, capitale morale del continente che ha visto il più alto tasso di motorizzazione globale, le amministrazioni più recenti stanno operando un ridisegno della viabilità cittadina per favorire la scelta, ormai diffusa, di muoversi in bicicletta e a piedi.

Al contrario a Roma, la città in cui vivo, l’amministrazione comunale ha scelto di fare orecchie da mercante, manifestando la più totale sordità alle richieste massicciamente avanzate dai cittadini ciclisti. Le ultime realizzazioni ciclabili, costose e dalla discutibile efficacia, risalgono alle giunte Veltroni. Dalla successiva consiliatura Alemanno alla caduca giunta Marino si è assistito ad un vero e proprio valzer di assessori, nella media totalmente disinteressati alla promozione dell’uso della bici ed alla salute dei cittadini, quando non apertamente contrari.
Gli attivisti romani hanno perciò preso spunto dal lavoro svolto in un’altra grande capitale nordamericana, Seattle. Si sono rimboccati le maniche ed hanno iniziato a tracciare segmenti di bike-lanes in tratti particolarmente a rischio della città. L’individuazione dei punti sui quali intervenire si è avvalsa in parte dell’esperienza diretta, in parte di un’analisi delle criticità urbane sviluppata dal sottoscritto.
La prima infrastruttura di questo tipo, apparsa all’interno del sottopasso di Santa Bibiana, è stata prontamente cancellata e, a breve distanza di tempo, ripristinata dai cicloattivisti. Ne sono seguite altre sotto la Stazione Tuscolana e su via Prenestina che, ignorate dall’amministrazione, sono state utilizzate a lungo dai ciclisti romani. Diverso destino per l’ultima nata, la “5th Avenue” (perché quinta in ordine di tempo e come rimando all’omonima via newyorchese, recentemente dotata di una apposita bike lane), realizzata pochi giorni fa su Ponte Principe Amedeo d’Aosta. Ecco come appariva l’opera appena completata.

A differenza delle precedenti (se si esclude Santa Bibiana), quest’ultima realizzazione è durata pochissimo. Le ‘truppe cammellate’ della manutenzione stradale, capaci di lasciare buche aperte per mesi e di ridipingere le strisce pedonali solo nella porzione di strada lasciata libera dalle auto in sosta vietata, a distanza di sole quarantott’ore sono corse a cancellarla, con un’urgenza altamente sospetta.

Questo è l’effetto finale della sistemazione dopo la cancellazione. Notare come il flusso di traffico ‘rispetti’ ugualmente il corridoio nonostante la cancellazione della linea bianca. Segno evidente che la scelta di destinare l’intera ampiezza della carreggiata al transito veicolare non è dettato da alcuna reale necessità, ma solo un portato della volontà di assegnare tutto lo spazio disponibile ad un’unica tipologia di veicoli.

Seattle, a differenza di Roma, ha mostrato una maggior intelligenza nell’accogliere le istanze dei cicloattivisti cittadini. Le bike lanes realizzate ‘clandestinamente’ sono state lasciate in funzione in via sperimentale, per verificarne la validità, ed in seguito acquisite come sistemazioni definitive della viabilità cittadina. Questo è quanto ci si potrebbe aspettare da un’amministrazione illuminata.

Il comportamento di quella romana, al contrario, manifesta unicamente la stolida volontà di continuare ad affermare un potere assoluto, esercitato a difesa di sistemazioni stradali ormai palesemente disfunzionali ed antistoriche, baluardo di una modalità di trasporto inefficiente, energivora e per più di un motivo ormai insostenibile e da ridimensionare. Cosa che tutte le altre grandi città del pianeta hanno compreso da tempo.
La sorte dei cicloattivisti romani continua a rimandarmi alla mente la scena della donna ingegnere ebrea nel film Schindler’s List, che corre dal comandante del campo per segnalare un rischio di instabilità strutturale nelle nuove costruzioni, e viene per questo giustiziata sul posto. Una volta avvenuta l’esecuzione, lo stesso comandante ordina che la struttura venga modificata come da lei indicato.

Che le modalità d’uso delle città siano destinate a cambiare in chiave di riduzione del traffico motorizzato è evidente a chiunque segua da un po’ le trasformazioni urbane in corso nelle grandi metropoli. Quello che le città italiane otterranno con questo ostruzionismo nel preservare utilizzi obsoleti dello spazio pubblico è altrettanto evidente: magri vantaggi per pochi soggetti economicamente forti ed un danno enorme in termini finanziari e di salute per l’intera popolazione. Personalmente avrei tanto desiderato un destino diverso per questo disgraziato paese.
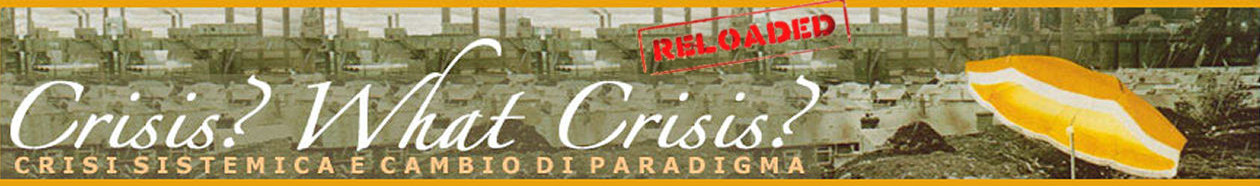
“Gli interventi da porre in atto ricadono in due grandi tipologie: limitazioni degli accessi veicolari da un lato, facilitazione dell’utilizzo di modalità di trasporto alternative all’automobile dall’altro.”
sommessamente aggiungerei un ricorso massiccio al telelavoro…o bisogna per forza uscire di casa? 😉
Il telelavoro andrebbe incentivato, ma correndo il rischio di sembrare all’antica non la ritengo una strategia valida sempre e comunque. Alla fine il posto di lavoro svolge una importante funzione sociale, ti mette in relazione con gli altri, ti obbliga al confronto con opinioni e punti di vista diversi dai tuoi, con saperi diversi dai tuoi. L’idea di un’organizzazione sociale nella quale ognuno è chiuso dentro casa e si relaziona solo col suo monitor la trovo francamente alienante.
Intanto c’è una buona notizia per i ciclisti: si è conclusa la persecuzione in tema di infortunio “in itinere”. Le circolari recenti, proprio in questi mesi, hanno equiparato la bicicletta a tutti gli altri mezzi di trasporto. Se ti tirano sotto mentre vai a lavorare, e se stai seguendo un percorso ragionevole, ora non possono più negarti l’infortunio sul lavoro semplicemente perché stavi utilizzando un mezzo proibito. Mi sono sorpreso di questa evoluzione, ma pare che sia cosa fatta.