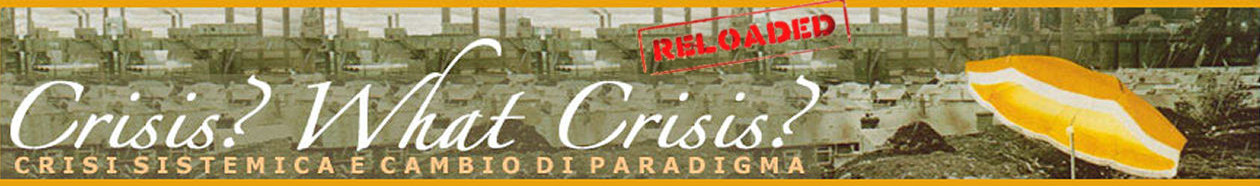Le discussioni seguite al post su Marte, ed al successivo di Jacopo sulla sovrappopolazione, ruotano tutte attorno ad un punto comune: lo scopo ultimo delle civiltà. L’aspettativa umana è che il nostro esistere, soffrire, lavorare, amare, lottare, abbia un senso di ordine superiore, pur se inafferrabile. Un’aspettativa, questa, retaggio del sentire religioso più che del pensiero scientifico, un sistema di idee all’interno del quale l’uomo viene al mondo per decisione di una (o più) divinità e la sua vicenda umana si inserisce in un ‘disegno superiore’, inconoscibile ma in qualche maniera ‘giusto’, perlomeno finché si seguono i dettati della divinità.
Questa esigenza di senso nasce dalla nostra capacità di operare scelte consapevoli, ragionate o dettate dal desiderio. L’impossibilità di stabilire a priori se una determinata scelta sia ‘quella giusta’ e non un tragico errore (un residuo di epoche in cui lottavamo per la sopravvivenza) ci ossessiona per l’intero arco vitale. L’unico sollievo a questa eterna incertezza ce lo danno i codici di leggi, le regole, le norme, i comandamenti. All’interno di un alveo rassicurante di comportamenti collettivamente accettati la nostra ansia di approvazione trova un momentaneo sollievo, rassicurandoci di stare operando ‘nel giusto’.
All’interno di una cultura tenuta insieme da convinzioni religiose condivise questo meccanismo svolge la funzione di stabilizzare la comunità. Ovviamente vi saranno individui con comportamenti istintivamente più votati all’ortodossia ed all’omologazione, e dal lato opposto temperamenti ribelli ed iconoclasti, ma nel complesso la società raggiunge un equilibrio. E se tale equilibrio non produce forzanti eccessive su un ecosistema già in condizioni critiche, tale cultura può stabilizzarsi e prosperare nei secoli.
Il fattore di disequilibrio, nel contesto attuale, è rappresentato dall’avvento del pensiero scientifico/razionale a partire da Galileo Galilei. Il pensiero scientifico, in sé, non si contrappone alla religione, esplora ambiti più ristretti, limitati all’indagine del reale a partire dalla sua conoscibilità. Le diverse teologie, ereditate da popolazioni molto antiche, contengono al proprio interno interpretazioni vetuste ed obsolete della realtà fattuale. Nel momento in cui diverse delle vicende descritte risultano contraddette dalle nuove scoperte, l’intero costrutto teologico ad esse connesso finisce col vacillare.
Nel nostro specifico, le fedi di discendenza israelitica (ebraismo, cristianesimo ed islam) mutuano la forma di ‘religioni rivelate’, ovvero discendono dalla trascrizione diretta di quanto comunicato dalla divinità stessa a personaggi storici (i profeti), o dall’incarnazione stessa della divinità (il Cristo). Il contenuto di tali rivelazioni non è questionabile, in quanto di diretta discendenza divina. Tutto funziona finché si permane nel contesto storico nel quale il dettato stesso è maturato, ma col progredire dei tempi e delle conoscenze accade facilmente che tale ‘dettato’ si scontri con le nuove acquisizioni del sapere.
Che succede quando ciò si verifica? Per il religioso sorge una contraddizione insanabile tra la realtà fattuale di cui fa diretta esperienza e la ‘parola divina’ che racconta una verità diversa ed inconciliabile. Può la divinità mentire all’Uomo? Nulla lo vieta, ma a questo punto viene a cadere la relazione di fiducia reciproca, perché un’ombra di diffidenza si estende all’intero codice comportamentale che il libro rivelato propone, all’intero corpus di leggi, norme, obblighi e convenzioni. Se Dio è ‘verità’ non può mentire, ma se il suo libro ‘mente’, rappresentando una realtà che non coincide con l’esperienza diretta, trovare un punto di quadratura può risultare impossibile.
Come si lega questa digressione teologica al discorso su Marte e sulla sovrappopolazione? Molto semplicemente perché le modalità usate dalle singole persone per giustificare il proprio agire vengono proiettate sugli aggregati umani (civiltà) di cui fanno parte, contribuendo alle narrazioni utilizzate per dare un senso al proprio esistere. Ogni civiltà della storia umana si misura con le precedenti in termini di potere, ricchezza e qualità della vita che riesce a garantire alle popolazioni.
Per i lunghi secoli del medioevo l’Europa è rimasta succube del mito della Roma imperiale, avendo visto progressivamente degradarsi le risorse umane, culturali e tecnologiche necessarie a riprodurre la ricchezza e lo sfarzo degli edifici e delle opere ingegneristiche dei secoli passati. Dall’esigenza di riottenere, e possibilmente superare, quel passato splendore sono nati il Rinascimento, il pensiero scientifico e la civiltà tecnologica attuale. Da quello stesso slancio, come superamento di un precedente ideale medioevale legato al recupero, alla cura ed alla conservazione, è nata l’idea di una civiltà proiettata ‘in avanti’, verso sempre nuove conquiste. Ma ‘avanti’ dove? Fino a che punto?
È in questo contesto storico-culturale che si sviluppano l’idea del progresso e l’invenzione del concetto di futuro. Le nuove macchine prodotte dalla rivoluzione industriale disegnano una prospettiva storica radicalmente nuova, uno stravolgimento degli usi, dei costumi, dei metodi produttivi e potenzialità di ricchezza e benessere prima inimmaginabili.
Per elaborare queste nuove prospettive la cultura popolare ha dato vita ad un genere letterario ex-novo legato alle fantasie scientifiche, in seguito denominato fantascienza, che ha finito col diventare parte integrante dei nuovi media, cinema e televisione. La narrazione fantascientifica mantiene l’attenzione popolare focalizzata su un’idea di futuro avveniristico dove l’umanità, finalmente trascese le spiacevolezze del vivere quotidiano, avrà conquistato nuovi spazi e nuovi mondi dove prosperare e vivere esistenze sibaritiche lontane da ogni obbligo o necessità.
Con ogni evidenza si tratta del paradiso ultraterreno, promesso post-mortem dalle fedi di discendenza israelitica, semplicemente trasposto al futuro della specie umana: una terra promessa di potere, ricchezza, lusso ed avventure ultraterrene, ma solo previa adesione alla narrazione culturale corrente, basata sulla prospettiva (indimostrabile) di sviluppo e crescita illimitati.
Ma appunto, di fantasie e narrazione opportunistica stiamo parlando. Così come le antiche religioni avevano la funzione di stabilizzare e rendere più resilienti le culture che le adottavano, istruendone i membri singoli e i gruppi sulle migliori modalità di relazionamento reciproco, così la cultura industriale e post industriale produce una narrazione ‘dinamica’ funzionale al proprio successo ed alla propria affermazione globale. Pur senza entrare (tranne rari casi) in aperto conflitto con le religioni tradizionali, la cultura dello sviluppo industriale arruola in continuazione nuovi ‘fedeli’ mentre espande le produzioni ed i mercati su scala planetaria.
C’è, tuttavia, un errore di fondo molto grave: la cultura industriale include una narrazione parziale, e di nuovo opportunistica, dei processi soggiacenti alla ricchezza prodotta. Il punto chiave è che processi di trasformazione distruttiva vengono descritti come generazione di ricchezza, quando nel complesso il danno prodotto supera di diversi ordini di grandezza il benessere provvisoriamente acquisito.
Nell’ultimo secolo abbiamo ottenuto un incremento nella produzione di cibo a spese della fertilità dei terreni e della biodiversità, abbiamo praticato l’overfishing fino alla distruzione di buona parte degli stock ittici globali, abbiamo tagliato foreste primarie per sostituirle con coltivazioni industriali, abbiamo estratto, e bruciato, petrolio e gas fossili riversando quantità terrificanti di sostanze nocive e velenose nella biosfera: nell’aria, nel terreno e negli oceani. Un processo di distruzione sistematica di ricchezza e varietà biologica su scala planetaria che è stato descritto come l’unico possibile progresso.
Nel saggio “Collasso. Come le civiltà scelgono di morire o vivere” Jared Diamond analizza diversi casi di civiltà che si sono scontrate, senza aver avuto modo di comprenderli o elaborarli, coi limiti degli ecosistemi nei quali si sono venute a sviluppare. In molti di questi casi si è trattato di culture insediate in terre appena scoperte, situazione che ha comportato un’erronea valutazione riguardo alla capacità di rigenerazione delle risorse disponibili.
I coloni vichinghi della Groenlandia provarono ad esportare la cultura e gli stili di vita europei in una terra molto più fredda ed ostile di quanto stimato. Tagliarono foreste che avevano tempi di ricrescita secolari con la stessa allegra baldanza con la quale aggredivano quelle europee, con tempi di ricrescita decennali. L’esito finale fu che in breve esaurirono la legna, quindi dovettero rinunciare alla metallurgia, più avanti all’allevamento, infine alla navigazione, finché di quegli avamposti lontanissimi e sperduti non rimase nulla, e nemmeno un abitante sopravvisse.
I polinesiani operarono la colonizzazione dell’isola di Pasqua intorno all’anno mille. Una terra talmente ricca da alimentare la crescita esponenziale della popolazione, che finì col dare vita a bizzarri riti religiosi in grado, in un arco di pochi secoli, di causare la completa distruzione della principale fonte di ricchezza: le palme giganti dell’isola. Una specie vegetale autoctona ora completamente estinta.
Ciò che mancò a quelle civiltà fu una narrazione realistica dei processi in atto, in grado di leggere le dinamiche in corso e comprenderne la prevedibile evoluzione. Un errore di natura culturale che innescò i processi di distruzione massiva degli ecosistemi ed il conseguente collasso delle civiltà stesse. Lo stesso errore che stiamo commettendo da tre secoli a questa parte, dopo che la rivoluzione tecnologica e scientifica ha completamente stravolto gli equilibri del ‘vecchio mondo’ trasformando l’intero pianeta nell’equivalente di una terra nuova e sconosciuta.
E, sebbene la nostra cultura possieda una narrazione alternativa degli eventi in corso, è incapace di darle ascolto, perché gli interessi immediati dei ‘predatori apicali’ della società non coincidono coi contenuti di tale narrazione. Stiamo parlando del “Rapporto sui Limiti dello Sviluppo” del 1972, commissionato dal Club di Roma al M.I.T. nei lontani anni ’70, le cui previsioni stanno, lentamente ma inesorabilmente, prendendo corpo.
Recita un vecchio adagio: “è difficile abbracciare una verità se i tuoi interessi immediati dipendono dal negarla”. Potremmo considerare una caratteristica intrinseca della nostra specie, o delle specie senzienti tout-court, quella di rimodellare la descrizione corrente del mondo per adeguarla alle necessità immediate. Potrebbe in effetti trattarsi di un difetto non eliminabile nella nostra architettura mentale.
E tuttavia se il percorso da intraprendere comprende il rimettere in discussione l’errore della narrazione illuminista, occorre che una diversa filosofia emerga a guidare il pensiero ed il sentire del mondo moderno, perché un’inversione di rotta diventi possibile e la catastrofe evitata. Una filosofia in grado di narrare un ruolo per l’umanità diverso da quello della conquista, della ricchezza, dell’accrescimento individuale e collettivo a spese di tutto e di tutti.
La cultura della decrescita dovrà essere innervata da un principio di responsabilità nei confronti del mondo. Da un’etica che contrapponga l’eroismo della rinuncia al successo determinato dal possesso. Da un’idea del sacrificio individuale in funzione del bene collettivo che le religioni, cristianesimo in testa, portano inscritte da millenni nel proprio DNA, e che già in passato ha guidato l’umanità attraverso epoche di povertà diffusa.
Più che di una vera e propria religione strutturata, con canoni, dogmi e misteri, avremo probabilmente necessità di una riscoperta dei valori della spiritualità. Qualcosa che possa definirci come parte di una collettività con comuni aspirazioni, che si trova a vivere su un mondo fragile la cui salute dipende dalle nostre scelte. Una condizione di cui la fredda e meccanica descrizione fattuale operata dalla scienza può renderci consapevoli, ma senza offrirci gli strumenti emotivi che ci consentirebbero di affrontarla adeguatamente.
Il fatto che le ultime speranze di questo ateo che scrive siano riposte in un ritorno collettivo ad un sentire spirituale/religioso abbandonato, anziché all’affermarsi definitivo del pensiero scientifico/razionale, è il paradosso più spiazzante della mia intera esistenza.