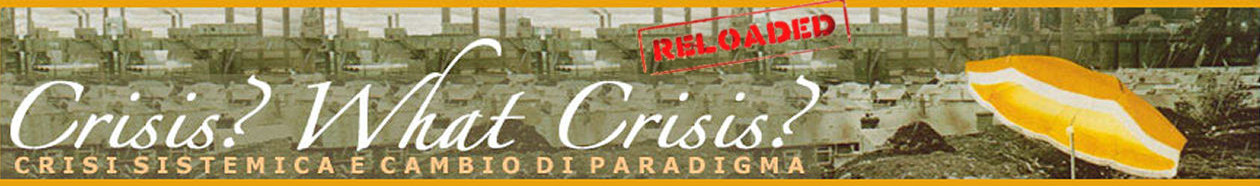Uno dei tanti paradossi che caratterizzano la nostra società è questo: man mano che la situazione ambientale degenera, la quantità di gente preoccupata di questo aumenta, ma il movimento ambientalista è sempre più debole e solo.
Chi non è più giovane, forse ricorderà che negli anni ’70 e ’80 il movimento ambientalista sembrava capace di cambiare la storia del mondo. Nelle sue infinite articolazioni, riusciva incidere in maniera avvertibile sulle decisioni politiche; almeno nei paesi occidentali dove esisteva una sostanziale libertà di stampa e di parola.
Eppure, allora, un collasso socio-economico ed ambientale di scala globale era considerato possibile non prima di 50 o 100 anni. Oggi invece, probabilmente stiamo vivendo le prime avvisaglie di un tale collasso, ma non si vedono orde di ambientalisti che, al grido di “Lo avevamo detto”, si impongono finalmente nelle sedi del potere. Piuttosto, sta accadendo esattamente il contrario: le politiche ambientali fin qui costruite vengono rapidamente smantellate, o svuotate di ogni efficacia. E gli ambientalisti o girano rapidamente la gabbana, o vengono estromessi non solo dalle “stanze dei bottoni”, ma anche dai corridoi e dagli sgabuzzini del potere.
All’interno della società, le associazioni storiche sopravvivono a stento ed i partiti “verdi” scompaiono, spesso dopo aver fatto magre figure.
E’ chiaro che ogni situazione particolare ha la sua storia ed i suoi problemi, ma il declino dell’ambientalismo è un fenomeno globale e, dunque, deve anche avere delle cause globali, oltre a quelle che riguardano, invece, questa o quella organizzazione particolare.
In qualità di veterano e superstite di questo movimento, mi sono posto alcune domande.
Prima domanda: C’è stato qualcosa di sbagliato alla radice del movimento?
Penso di si, ma non essendo un politologo, posso proporre solo delle riflessioni basate sull’esperienza personale.
Nel suo insieme, l’ambientalismo non ha saputo elaborare e divulgare un paradigma politico alternativo ai due che, all’epoca, si contendevano la scena: il liberalismo ed il socialismo. Molto presto infatti, la maggior parte degli aderenti e delle organizzazioni ambientaliste si sono lasciate aspirare e stritolare nella dialettica destra-sinistra che nulla aveva a che fare con il cuore del problema. In pratica, il movimento si è diviso in due. Da un lato coloro che pensavano che il sistema liberal-capitalista fosse sostanzialmente valido, salvo introdurvi delle correzioni per garantire un adeguato livello di tutela ambientale.
Sull’altro fronte coloro che, viceversa, ritenevano valido il modello socialista che, con alcune integrazioni, avrebbe potuto frenare il degrado degli ecosistemi, l’esaurimento delle risorse, ecc.
In pratica, da entrambe le parti si è pensato di migliorare quello che già era disponibile, anziché elaborare qualcosa di autenticamente originale.
Eppure, al di la dei parziali e limitati successi che entrambi gli schieramenti possono effettivamente rivendicare, non avrebbe dovuto volerci molto a capire che si trattava di posizioni perdenti a priori. Sia il capitalismo che il socialismo perseguono infatti il progresso indefinito della società. La differenza fra di essi non è quindi negli scopi ultimi, ma su quali siano i mezzi migliori per perseguirli, quali i modi più efficaci per accelerare il progresso e come ripartirne i benefici frutti.
Entrambi i filoni dell’ambientalismo, accettando e facendo proprio il corpus centrale delle due dottrine socio-economiche di rispettivo riferimento, necessariamente hanno fatto proprio il nucleo centrale che le accomuna: il Progresso. Un archetipo, che si porta dietro un vasto corollario di conseguenze e che nessuna analisi dei fatti potrà mai scalfire in quanto si tratta, tipicamente, di un postulato pre-analitico (Daly, Ecological Economics 2004).
A mio parere, era invece proprio l’archetipo del progresso che avrebbe dovuto essere messo in discussione, ma ciò avrebbe significato attaccare la radice stessa del pensiero moderno alla cui origine troviamo padri del calibro di Bacone, Galileo, Cartesio, Hobbes, Boyle, ecc. Un filone di pensiero poi sviluppato dall’illuminismo e santificato da 2 secoli di scuola pubblica. Difficile immaginare un compito più arduo.
Del resto, perfino nelle pagine della prima edizione dei “Limiti dello sviluppo” si leggeva tra le righe una diversa impostazione fra Donella e Denis Meadows; una diversità che si è andata poi palesando meglio nelle edizioni successive. Il risultato finale del loro studio era infatti chiaro: qualunque risulti essere la dotazione di risorse del pianeta e qualunque sia il livello di tecnologia raggiungibile, il collasso del sistema sarà inevitabile ed il nostro destino tanto più fosco quanto più abbondanti saranno le risorse e potenti le tecnologie. Unica via di uscita dalla trappola era fermare la crescita demografica e la crescita economica prima di raggiungere una soglia critica che non era definibile con certezza, ma che si sapeva non essere lontana.
Un messaggio chiaro che andava totalmente e direttamente contro l’intero apparato filosofico ed ideologico della “modernità”, chiudendo definitivamente con il mito delle “magnifiche sorti e progressive dell’umanità” (Leopardi, La Ginestra).
Qualcosa di talmente forte che neppure tutti i membri del gruppo erano pronti ad accettare, a cominciare dalla stessa Donella che volle mitigare il messaggio. In fondo, disse, se facciamo sempre meglio con sempre le stesse cose, e non aumentiamo di numero, perché non dovremmo migliorare indefinitamente le nostre vite? In altre parole, si pensò che fosse possibile distinguere fra uno “sviluppo insostenibile” fatto soprattutto di crescita quantitativa ed uno “sviluppo sostenibile” fatto di buone pratiche, solidarietà sociale ed efficienza industriale.
Oggi che “sviluppo sostenibile” ed “efficienza” sono divenute le parole d’ordine dei più folli e disperati tentativi per rilanciare una crescita oramai da un pezzo anti-economica, il loro suono risulta quasi osceno. Ma all’epoca furono le parole d’ordine su cui si strutturarono entrambe le anime dell’ambientalismo: quella liberale e quella socialista. Ed esattamente questo fu, a mio avviso, l’errore che fece smarrire la strada a tutti noi che, a quei tempi, raccoglievamo fondi per salvare la Foca monaca o ciclostilavamo volantini nei sottoscala.
A mio avviso, per essere efficace, il movimento ambientalista, avrebbe dovuto capire subito che il nemico erano i miti fondanti della modernità. Dunque una rivoluzione ben più radicale di quelle di moda all’epoca, e questo ci porta alla seconda domanda.
Seconda domanda: Avrebbe potuto andare diversamente?
Da subito, il progetto ambientalista si incagliò su numerosi scogli. A mio avviso, due dei più importanti, che peraltro non vengono mai trattati, furono le conseguenze che politiche efficaci sul piano della sostenibilità avrebbero potuto avere sugli equilibri geo-politici e sulle politiche sanitarie.
Frenare la crescita economica avrebbe probabilmente comportato un parallelo rallentamento del progresso tecnologico. USA ed URSS (con i relativi satelliti) erano allora impegnati in uno scontro formidabile per il controllo del pianeta e nessuno dei due contendenti era in grado di assumersi un tale rischio. Men che meno il blocco occidentale che aveva adottato (con successo) una strategia fatta di un dispiegamento di forze quantitativamente molto inferiori, ma tecnologicamente più avanzate.
Così ci si concentrò sull’aspetto demografico e qualcuno ricorderà che, allora, la sovrappopolazione era un argomento sulla bocca di tutti.
Alcuni paesi avviarono anche delle concrete politiche di riduzione delle nascite, in particolare l’India (poi abbandonate) e la Cina (tuttora vigenti in forma attenuata), ma nessuno si sognò neppure lontanamente di mettere in discussione gli effetti demografici che il fulmineo progresso della medicina stava avendo in tutto il mondo. Eppure, non è certo un segreto che la demografia dipende dall’equilibrio fra nascite e morti. E che, con animali molto longevi come l’uomo, gli effetti di fluttuazioni anche modeste da entrambe le parti hanno effetti complessi, destinati a farsi sentire nei decenni. Un argomento politicamente minato ancor oggi, tanto più allora che avevamo una salubre memoria delle follie criminali di Hitler e Stalin. Così, si preferì evitare l’argomento, sperando che la “transizione demografica” avrebbe risolto il problema da sola ed in tempo. In pratica, ci si affidò alla crescita economica per risolvere i problemi che questa stessa creava. Difficile che potesse funzionare ed infatti non ha funzionato, ma sarebbe stato possibile affrontare diversamente l’argomento con un minimo di probabilità di successo? Penso di no.
Un’altra ragione per cui, a posteriori, penso che non avrebbe potuto andare diversamente era la possibilità di comunicare il nostro messaggio. In buona parte del mondo (Russia, Cina e molti altri), semplicemente era vietato. Nei paesi occidentali era invece permesso, ma il nemico da battere si è dimostrato capace non solo di assoldare una parte dei quadri del movimento, ma anche fare proprie la retorica e la dialettica ambientaliste. Assorbirne gli slogan, modificandone il significato così da renderlo funzionale al proprio scopo fondamentale: la crescita. E poiché il significato delle parole cambia nel tempo a seconda di come queste vengono impiegate, ad oggi è giocoforza ammettere che il capitalismo ha vinto non solo sul piano politico, ma prima ancora su quello semantico.
Ma anche al di la questi ed altri ostacoli, quali potevano essere le probabilità di successo di un movimento politico che, per essere coerente, avrebbe dovuto predicare la fine del progresso e del benessere materiale per tutti?
Finquando si è trattato di dire ai benestanti cittadini occidentali che dovevano rinunciare a quota parte del loro benessere, in molti si sono fatti avanti a dirlo, anche se con scarsi risultati (cfr. il rapporto Europa sostenibile e gli scritti di S. Latouche, fra i numerosi altri). Ma era evidente che sarebbe stato del tutto inutile se, contemporaneamente, tutti gli altri popoli della terra non avessero rinunciato ad acquisire un analogo benessere: una cosa talmente “politicamente scorretta” che praticamente nessuno ha finora avuto il coraggio di dirla. Ma neppure ciò sarebbe bastato.
Giunti alle strette degli anni ’70, fermare la crescita demografica era imperativo e non poteva essere fatto senza porre dei limiti al progresso della medicina. Una cosa assolutamente improponibile, con ottime ragioni perché fosse così.
Dunque l’ambientalismo politico si trovò da subito stretto in un’impasse che avrebbe potuto essere superata solo con un radicale cambio di paradigma; un salto culturale talmente grande da non essere neppure tentato.
Schopenhauer diceva che solo ciò che poi accade era davvero possibile che accadesse. Personalmente condivido solo in parte tale illustre opinione, ma nel caso in esame penso che si possa applicare pienamente.
Terza domanda: Ad oggi continua ad avere un senso fare dell’attivismo ambientalista? Se si, Quale?
Bisogna ammettere che oggi è particolarmente imbarazzante fare discorsi ambientalisti. Che dovremmo dire? La maggior parte delle organizzazioni ancora attive continua a “suonare” allarmi ormai consunti dall’uso e dall’abuso. Che senso ha continuare a dire che “se non facciamo questo e quest’altro avverrà una catastrofe”, quando la catastrofe è in corso e non ha spostato di una virgola la direzione del sistema?
L’esempio più facile è quello del clima. 30 o 20 anni fa era giustificato dire: “Se non riduciamo le emissioni il clima peggiorerà e farà dei danni”. Che senso ha ripeterlo oggi, mentre sui teleschermi le immagini di alluvioni e siccità, tornado ed uragani si alternano quotidianamente alla pubblicità dell’industria energetica ed agli appelli per il “rilancio della crescita”? E con tale naturalezza che non ci si accorge nemmeno più della schizofrenia della cosa.
D’altronde, che senso può avere andare in giro a dire che tanto oramai non c’è più niente da fare? A parte che ciò facilmente suscita reazioni ostili e gesti osceni, rischia anche di servire da pretesto per rimuovere anche i pochi veli di protezione che ancora mitigano la follia autodistruttiva del sistema economico.
La risposta, ritengo, dipenda essenzialmente dallo scopo che ci si prefigge. Se ci si danno finalità possibili, c’è sempre un senso a fare qualcosa.
Lo scopo di partenza, dirottare il mondo su di un cammino di sostenibilità è fallito, ma abbiamo altre possibilità di azione.
La prima sta venendo di moda con l’etichetta di “resilienza”. In estrema sintesi, si tratta di questo: preso atto dell’inevitabile, possiamo comunque prepararci in una certa misura agli eventi futuri ed aumentare le probabilità di sopravvivenza nostre e quelle dei nostri parenti ed amici.
Si tratta di un campo praticamente sterminato, totalmente da inventare in cui ognuno può rendersi utile anche solo proponendo idee e consigli. Magari sbagliati, ma comunque capaci di stimolare altre idee in altre persone.
La seconda è che se non possiamo fare quasi più niente per migliorare il nostro destino, possiamo invece fare tantissimo per peggiorarlo ulteriormente.
Anche solo evitare di fare cose stupide sarebbe un grandissimo vantaggio ed in questo penso che rivesta un ruolo importante la divulgazione scientifica. Se si riesce a capire, almeno in parte, cosa sta succedendo e perché, sarà meno facile farsi abbindolare da chi promette l’impossibile, naturalmente a patto di votarlo o di comprare i suoi prodotti.
Una terza possibilità di azione riguarda il futuro remoto; quelle “bottiglie gettate in mare” di cui parla Edgar Morin (La via 2012). Nessuno può sapere quale aspetto avrà il collasso visto dal nostro punto di vista, e neppure quanto tempo prenderà, né quale sarà il nostro personale destino. Ma possiamo contare sul fatto che le doti di resistenza e resilienza della specie umana faranno sì che, quando la vegetazione coprirà le rovine delle nostre megalopoli, ci saranno degli uomini a discutere di cosa siano quei grandiosi ruderi. Possiamo fare qualcosa ora per aiutarli? Io penso di si.
Oggi disponiamo di un patrimonio di conoscenze scientifiche e di arte in ogni forma possibile, che sarebbe veramente stupido e criminale lasciar morire con noi. Io penso che dovremmo preoccuparci di divulgare il più possibile questo immenso patrimonio, proteggerne la parte materiale (opere, monumenti, musei, libri, ecc.) in modo da accrescere le probabilità che parte di tutto questo sopravviva alle fasi più violente e disperate del disfacimento della nostra civiltà. Molte delle opere che ci sono giunte dal nostro remoto passato sono sopravvissute grazie a persone che le hanno copiate, nascoste, protette, tramandate. Noi abbiamo in questo campo una possibilità praticamente infinita di azione.
In conclusione
Ritengo che il movimento ambientalista fosse in partenza destinato a fallire il suo scopo principale, ma non è stato per questo inutile.
Se il filone principale del movimento non ha potuto scalfire i paradigmi della civiltà moderna, l’ambientalismo ha nondimeno influenzato importanti frange del pensiero contemporaneo, creando i presupposti perché dei paradigmi veramente alternativi possano nascere, o rinascere, contribuendo forse in modo importante alla formazione delle civiltà che, probabilmente fra qualche secolo, si diffonderanno sulla Terra.